Davide Mansueto Raggio
Genova // Ospedale psichiatrico di Quarto
Datazione incerta,probabilmente fine anni 80
La mia storia con l’ospedale Psichiatrico di Quarto ha antichissime radici, direi
1964/1965. Da bambino passeggiavo con la nonna chiedendole :- ” …nonna ti
prego…andiamo dai matti? “
Il termine “matti” ebbe però breve vita nel mio personale vocabolario.
Più grande aggiunsi che vivevo in una specie di triangolo delle Bermude, tra
l’ospedale psichiatrico, il centro infanzia abbandonata (IPPAI) e il cottolengo di
Don Orione. Confesso, concedetemi l’accento polemico, di non aver dovuto
aspettare la riscoperta della grandissima Alda Merini per capire che molto di
ciò che la società definisce “guasto” e mette da parte merita “attenzione”.
Il mio unico ” vero maestro” S.G. colui che mi spiegò e portò a vedere il mondo
in modo diverso e pazientemente mi educò alla stampa fine art finì poi a Quarto
per un lungo periodo per drammatiche vicende personali.
A Quarto c’era Claudio Costa, adoravo il suo lavoro…passavo dall’Istituto per le
materie e forme inconsapevoli, lì nel 1988 iniziai in una palestra col giovane
gruppo ARBALETE a sperimentare la foto di danza…e sempre all’Ospedale
psichiatrico, nel 1994 tributai il mio amore ambientandoci alcuni dei miei
famosi Angeli ( vedere NEL SEGNO DELL’ANGELO nella sezione portfolio).
Ebbi quindi modo di incontrare e conoscere, Davide Mansueto Raggio, uomo
mite intriso di delicata poesia. Riconobbi il suo volto a partire dalle linee della
bocca, poi scalai il suo grande naso che mi ricordava un meteorite e da lì mi
tuffai a bomba nell’immensità del suo sguardo. I materiali poveri raccattati per
strada divenivano il suo modo per CREARE STRANI PERSONAGGI e da vero
“attante” condurre chiunque lo desiderasse nel suo piccolo mondo.
Se nel nome è celato il destino, dirò che un mansueto raggio d’ombra in
periferia può indicare la via più di cento dardi assolati.
Se nel nome il fato ci appare sornione, dirò che Davide ha scagliato quel sasso
con la sua piccola fionda di vitalba intrecciata, costruita di getto in quella
candide ore che escono piano dal buio (quando gli altri non pigliano pesci),
contro la fronte ottusa, maestosamente grande di compar Pregiudizio. Dalla
Fronte e dal Sasso, Artevenere è nata, la Bella mai abbastanza amata, andata
un giorno in sposa a messer Boscofitto.
Quindi, hanno visto la luce Sassomatto e Lungobacco, fratelli di alterni
conflitti. Se il fratello ha ucciso il fratello come vuole tradizione, madama
Cortecciadipinta ha salvato quella solida stirpe che scendeva diretta
dalbizzarro Quadrincollato.
Che narrar, ora, degli ultimi nati, dopo il vetusto, lungo impero dell’asciutto
Piattorilievo? Che sono frugoletti dalla chioma vivace? Scarmigliate sorelle
dal sangue legnoso dei Cestini dal cuore fiorito? Se nel nome è nascosto il
segreto, dirò che è la furia di fiamma a riunire, più spesso, agli Dei, più di
cento meste preghiere.
Claudio Costa
Genova-Quarto, giugno 1990
1926 – Nasce a Celesia (località Pianella) in Val Cichero, Comune di San Colombano Certenoli, il 26 giugno. Suo padre, Davide, è deceduto tre mesi prima, il 20 di marzo. Prima di lui erano nati Gian Battista (1911), Giacomo Giovanni (1912), Maria Beatrice (1916), Achille Pellegro (1919).
1927 – La madre, Maria Giovanna Giambruno, si risposa con Giulio Del Soldato. Nascono Gina (1927), Emma (1929) e Pina (1932).
1936 – Il 7 agosto la famiglia si trasferisce a Certenoli per condurre a mezzadria le terre dei “Dòneghi”-Simonetti.
1944 – Davide Mansueto è chiamato alle armi. Il 2 settembre viene messo nel plotone di esecuzione per la fucilazione di Ambrogio Giannotti, residente come lui a Certenoli. Si rifiuta di farne parte ma lo costringono ad assistere all’esecuzione. Quindi per punizione lo inviano sul fronte della Garfagnana in prima linea. In uno scontro viene fatto prigioniero dagli americani e internato in un campo di concentramento in Toscana.
1945 – A maggio viene messo in libertà e può tornare a casa. È irriconoscibile, non sta bene. I traumi subiti hanno inciso sul suo fisico e sulla sua salute mentale. Fa fatica a inserirsi nel contesto locale. Collabora con i familiari nei lavori agricoli e fa qualche giornata presso altre famiglie.
1950 – Va a fare il taglialegna nella faggeta del monte Ramaceto, con una piccola squadra di operai. Prosegue questa attività anche nel 1951.
1952 – Emigra in Argentina, a Buenos Aires, presso il fratello Achille Pellegro emigrato nel 1950. La decisione di emigrare è maturata l’anno precedente. La tassa di espatrio risulta infatti versata nel novembre 1951. Sul passaporto il visto di ingresso reca la data del 23 maggio 1952. A Buenos Aires Raggio trova lavoro in una ditta di acque minerali.
1956 – Coinvolto (in anni precedenti al ’56) in attività antigovernative, dopo un periodo di internamento fa ritorno in Itala. Rientra con la motonave “Caboto” e sbarca a Genova il 25 giugno. Le sue condizioni psichiatriche sono peggiorate. Nel mese di settembre si allontana da casa. Lo cercano per giorni e giorni e infine viene rintracciato sul Ramaceto. Riaccompagnato a casa, ai primi di ottobre entra nell’ospedale psichiatrico di Quarto, dove trascorrerà 46 anni.
2002 – Il 22 maggio cessa di vivere nell’ospedale di Recco dove era stato ricoverato dopo un breve periodo di soggiorno a Casa Michelini a Genova.
Renato Lagomarsino
da Davide Mansueto Raggio. Un artista fuori dal tempo
Quaderni del Lascito Cuneo, 2014
Lo ricordo bene, Davide Mansueto Raggio. Aveva qualche anno più di me e
viveva a Certenoli, dove c’è la chiesa parrocchiale, che, salendo da Calvari,
frequentavo per la messa domenicale, per le feste maggiori o, da ragazzo, per la
“dottrina”.
Viveva con i suoi in una vecchia casa (in tempi recenti ristrutturata) sulla cui
facciata c’era (e c’è ancora) una targa in ardesia con una scritta in latino.
La sua famiglia, nell’agosto del 1936, si era trasferita da Celesia, una località
della non lontana Val Cichero, a Certenoli per condurre a mezzadria le terre dei
“Dòneghi”, una famiglia benestante del posto.
Mansueto (così era conosciuto) era nato a Celesia il 28 giugno del 1926 da
Giambruno Maria Giovanna e Davide Raggio, deceduto tre mesi prima che lui
nascesse. La madre, che con Davide aveva già avuto, oltre a Mansueto, altri
quattro figli, nel ’27 si era risposata con Giulio Del Soldato, dal quale ebbe altri
tre figli: Gina, Emma e Pina.
A Certenoli si erano ambientati molto bene, tra gente adusa come loro alla
fatica: fasce da coltivare, bestie nella stalla, olive da “battere” e castagne da
raccogliere.
Quando Mansueto compì i diciott’anni, nel 1944, eravamo in piena guerra.
Anzi, qui da noi si stava vivendo il periodo più tragico, quello della guerra civile
e della lotta contro le truppe d’occupazione naziste.
Sui monti, già alla fine del ’43 si erano formati gruppi di “ribelli”. Il primo
proprio in Val Cichero, nel Casone dello Stecca, a ridosso del Passo di Romaggi.
Qui c’erano Aldo Gastaldi, Giovanni Serbandini, G.B. Canepa, che diverranno i
capi della Resistenza nell’entroterra di Chiavari assumendo i nomi di
“Bisagno”, “Bini” e “Marzo”.
Con loro, da Certenoli, era salito Rinaldo Simonetti, anche lui del ’26 e
coetaneo, dunque, di Mansueto. Un ragazzo vivace, che probabilmente prese
quella decisione più per spirito di avventura che per un ideale.
L’alternativa avrebbe potuto essere, al momento della chiamata di leva,
compiendo i diciott’anni, la vita da recluso tenendosi nascosto da qualche
parte, oppure rispondere alla chiamata presentandosi.
Nel ’44 si aveva l’impressione che la guerra volgesse alla fine. Il fronte era a
Carrara, sulla “linea gotica” e si udivano i cupi rombi delle cannonate in
lontananza. Mansueto quando arrivò la cartolina si presentò a Chiavari dov’era
stato convocato. A Chiavari c’era Spiotta con le “brigate nere”, che proprio in
quei giorni stava dando sfogo al suo odio contro i partigiani e i loro sostenitori
con condanne a morte senza processo. Tra i destinatari ad essere fucilati c’era
Ambrogio Giannotti, lombardo di origine, con otto figli in giovane età. Poco
prima della guerra era venuto a Certenoli “a manente” nelle terre dei Solari.
Non si sa per quale motivo fosse stato catturato. Forse perché quando aveva un
bicchiere di troppo diceva male del fascio, cosa che a Spiotta non andava bene.
Mansueto, da poco “in servizio” a Chiavari, venne messo a far parte del plotone
d’esecuzione, ma quando vede che il condannato è Ambrogio, il suo vicino di
casa, si ribella. “Per me è come fosse mio padre, io non ci sto – dice – mi
rifiuto…”. Lo accontentarono, ma dovette assistere alla fucilazione. Poi gli
dissero “ora tu devi scegliere: o ti spediamo in Germania oppure ti
mandiamo al fronte, in prima linea”. Mansueto preferì il fronte. “Per lo meno –
racconta la sorella Emma – se muoio, muoio in Italia”. E lo mandarono in
Garfagnana, tra gli alpini della “Monterosa” che stavano tentando di frenare le
truppe alleate.
In uno scontro Mansueto venne fatto prigioniero dagli americani. Internato in
un campo di concentramento in Toscana, vi rimase fino al maggio del ’45.
Non appena libero, con mezzi di fortuna fece ritorno a casa. Ma non scese a
Chiavari. Proseguì per Rapallo perché prima volle salire a Montallegro per
ringraziare la Madonna. Emaciato, dimagrito e stravolto, in famiglia quasi non
lo riconobbero. In effetti non era più il Mansueto di prima. La fucilazione di
Ambrogio, la morte in faccia sul fronte, la fame nel campo di
prigionia avevano alterato il suo equilibrio psichico. Il ritorno alla vita normale
(che poi era il lavoro nei campi) appariva turbato da questi fantasmi che
riaffioravano e non gli davano tregua.
Agli inizi del 1950, mio padre (che purtroppo mancò poco
dopo), aveva acquistato, in società con altri, la faggeta del Ramaceto per farne
legna da ardere. Mansueto viene chiamato a far parte della squadra di boscaioli
che deve impiantare la teleferica e procedere al taglio delle piante. A capo del
piccolo gruppo c’è Marchin, Marco Parodi, un uomo ingegnoso, capace di fare
qualsiasi cosa, ma soprattutto di animo buono. Conosce Mansueto, sa dei suoi
problemi e lo tratta come un figlio.
Sul Ramaceto, nel folto della selva, con i tronchi costruiscono una baracca. Sarà
quello, per due anni, il loro alloggio fino all’arrivo dell’inverno, ma il sabato
tornavano a casa. Andai a trovarli alcune volte. Il 2 giugno del 1950 mi
portai anche la macchinetta e feci alcune foto. Ricordo che era una giornata
scura, aveva fatto temporale ed eravamo arrivati, io e mio fratello Bruno, che
era ancora un fanciullo, bagnati fradici. Ci riscaldammo, mangiammo la
polenta con loro e prima di venir via scattai alcune foto.
Ora queste immagini, seppure non ben riuscite, sono un documento.
Consentono infatti di colmare una lacuna e di rettificare la biografia di Davide
Mansueto Raggio.
L’emigrazione in Argentina avvenne dopo, nel 1952, e lo testimonia il
passaporto, che la sorella Emma ha conservato. Il timbro di ingresso porta la
data del maggio ’52. A Buenos Aires aveva un fratello, Achille Pellegro Raggio,
che gli trova un posto in una ditta di acque minerali.
Coinvolto non si sa come, ma forse per ingenuità e a cagione dei suoi problemi
di salute, in attività antigovernative, viene dapprima internato e quindi
rispedito in Italia. Viaggia sul piroscafo “Caboto” e arriva a Genova il 25 giugno
del 1956. Ad attenderlo ci sono i suoi familiari, che cercano amorevolmente di
reinserirlo nella vita di famiglia, ma con scarso successo. Sul finire di settembre
Mansueto infatti sparisce. Lo cercano in tanti, con quella partecipazione
spontanea e solidale propria della gente di paese, ma non lo trovano. Finché
giunge notizia che è stato visto sul Ramaceto, in mezzo alla foresta di faggi.
Pastori della Ventarola che conducevano il bestiame al pascolo, ed altri di
Cichero, lo avevano incontrato e gli avevano dato qualcosa da mangiare.
Il Ramaceto, una delle montagne sacre degli antichi liguri, maestoso nel
suo anfiteatro di roccia e folto di piante sul versante dell’Aveto, dove
Mansueto aveva fatto vita da boscaiolo fra il ’50 e il ’51, era diventato in quei
giorni di fine estate, il luogo ove rifugiarsi per dare spazio alle sue fantasie.
A farlo tornare a casa ci riuscì suo padre, il buon Giulio, che fingendo di andare
per funghi lo incontrò nel bosco e lo convinse a seguirlo. Con sé portava dei
legni che aveva inciso col temperino: le prime di tante opere d’arte che avrebbe
fatto in seguito, durante i lunghi anni di permanenza nell’ospedale psichiatrico,
dove venne ricoverato subito dopo, nell’ottobre del 1956.
Aveva da pochi mesi compiuto i trent’anni. Altri quarantasei li avrebbe
trascorsi là dentro.
Testo di Emanuela Iovino:
“La vita è l’arte dell’intreccio”, scriveva Borges nelle sue Finzioni, chiarendo come la storia dell’uomo non si risolva in un singolo percorso lineare, ma nel groviglio discontinuo che solo il caso è capace di donarle. Se nell’intreccio di spazio e tempo, di amore e morte si tesse la vita, spesso è nella trama casuale della vita che l’artista opera, ricercando l’essenza profonda dell’essere tra le maglie inconsapevoli della propria esistenza. E’ una ricerca complessa, nella quale la coscienza cede il passo all’inconsapevolezza delle forme, alle espressioni immediate, ai segni puri di uno sguardo che riesce a scorgere l’infinito oltre la siepe della realtà. Su questo sentiero ombroso in cui l’osservazione del reale genera l’irreale, in cui il canto dell’uomo genera l’incanto dell’arte, si situa la storia dell’intreccio tra due artisti nella Genova della fine degli anni Ottanta, Claudio Costa e Davide Mansueto Raggio. E’ la storia di un’amicizia che nasce tra le mura dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, e che fa di quelle mura un luogo di condivisione, di arte, di vita.
Claudio Costa è un artista fuori dagli schemi, che vive gli inizi dell’arte povera nella metà degli anni Sessanta a Genova, ma che difficilmente si può inquadrare in una corrente artistica: un artista borderline, che aveva scelto l’uomo come tema centrale di ricerca, a partire dal quale indagare lo spazio, il tempo, la trasformazione della materia, per ricondurre tutto all’Essenza universale. Anche Davide Raggio è un artista fuori dagli schemi, per 43 anni internato nel manicomio di Genova Quarto, trova nell’arte un mezzo per dialogare col mondo e con la parte più oscura di sé, per esprimere attraverso le opere quell’essenza profonda che sentiva gravare nella coscienza. Nella storia di questa amicizia, nel valore di questo incontro gioca un ruolo fondamentale l’inconsapevolezza, o meglio, quel piccolo scarto tra la coscienza e la conoscenza, tra la ragione e l’istinto, tra la volontà e il caso, che solo l’arte è capace di mostrare. Il luogo in cui avviene questo incontro alchemico[1] è l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, dove, con la guida illuminata ed accorta di Antonio Slavich, dalla fine degli anni Ottanta si diede vita ad uno straordinario esperimento di annullamento delle mura sociali e culturali dell’ex manicomio, arrivando alla creazione del Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli nel 1992, divenuto poi nel 1995, in seguito alla precoce scomparsa dell’artista, Museo Attivo Claudio Costa[2].
Le radici del Museo Attivo vanno rintracciate in quel fermento culturale che invase l’ex Ospedale Psichiatrico negli anni successivi all’attuazione della legge Basaglia, quando, aperto formalmente alla città, divenne un centro pulsante nel quale confluirono varie associazioni e cooperative di volontari, che portarono nel 1988 alla fondazione, presso il Servizio di Salute Mentale della XVI USL di Genova, dell’Istituto delle Materie e delle Forme Inconsapevoli. I protagonisti di questa organizzazione di volontariato furono artisti, operatori sociali, giovani, uniti dall’intento di «rompere l’isolamento intorno ai luoghi della malattia mentale, e contaminare il manicomio con la vita»[3]. In questa atmosfera si organizzarono atelier di arteterapia, performances, spettacoli teatrali, nell’idea di trasformare l’ex ospedale in un luogo vivo, con-fuso con la città. Si realizzarono mostre nelle quali si esponevano in maniera continua e indifferenziata opere di artisti professionisti e opere di degenti, frutto dei laboratori di tecniche espressive, raccolte poi in quello che nel 1992 diventerà il Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli. Nelle intenzioni dell’Istituto e del Servizio Mentale il Museo diventava il centro nevralgico di quel fermento culturale, «un luogo di feconda invenzione, in grado di veicolare idee atte a spezzare la sorda parete del silenzio che spesso si crea attorno alle disabilità mentali»[4].
Osservato a quasi venti anni di distanza il Museo Attivo dimostra tutta la sua forza innovativa e di avanguardia: un museo in cui si espongono opere senza etichette, senza distinzioni tra l’inside e l’outside del sistema dell’arte, per poter offrire al visitatore una visione totale ed esclusiva dell’opera, annullando i distinguo dei singoli autori in nome della forza espressiva dell’arte, dal momento che lo «sforzo che un malato mentale deve compiere per esprimersi graficamente non è meno arduo di quello che un individuo qualsiasi fa per chiamarsi Artista»[5]. In realtà, i venti anni che ci separano dalla creazione di questo originale Museo permettono di vedere anche tutto il fallimento di quell’utopia, figlia di un’altra epoca e probabilmente di un’altra etica, che si è scontrata, negli anni, con la miopia delle istituzioni, con l’avvicendarsi di rifiuti, non curanze, indifferenze, che ha ridotto oggi il Museo Attivo a due corridoi dell’attuale Centro Basaglia, costringendo a rinchiudere la maggior parte delle opere in un magazzino, ironia della sorte, vicino all’ex obitorio manicomiale, in uno stato di conservazione gravemente precario.
Oggi lo sguardo di chi entra nel Museo Attivo Claudio Costa incontra due opere suggestive, molto diverse tra loro, come due presenze silenti e attente: una è un’opera dalle grandi dimensioni di Claudio Costa, dal titolo Macchina Alchemica, una sorta di maschera tribale dal profilo ieratico che a ben vedere costituisce anche il corpo di un insetto dallo sguardo vigile e affilato, che a sua volta cela nel proprio corpo una bottiglia straboccante di stelle. L’altra è una Furia di Davide Raggio, una scultura di legno, con le braccia tese verso l’alto, le gambe divaricate come nel principio di una danza, i capelli mossi dal vento, e gli occhi straniati che sembrano fissare un punto lontano. E’ nella casuale e caotica sinergia tra queste opere che si può cogliere ancora l’intreccio vitale dell’arte che ha animato quel luogo e che ha unito i percorsi dei due artisti, dei due amici.
Quando Claudio Costa comincia a collaborare al distretto di salute mentale è già un artista affermato, con alle spalle importanti esposizioni internazionali come quella di Documenta 6 a Kassel nel 1977 e con un percorso artistico piuttosto autonomo rispetto al dominante panorama concettuale e poveristico di quegli anni. Alla fredda purezza dell’arte concettuale preferisce la dimensione calda e vissuta degli oggetti, e alla trasformazione della materia, cara all’arte povera, preferisce ricercare l’origine delle cose, risalire attraverso la regressione allo stato primigenio dell’universo. Teorizza così il work in regress, in opposizione al work in progress di James Joyce[6], come un lavoro di ri-costruzione antropologica che ci riporta al magico, al mito, al rito, a culture lontane. Creare diventa ri-creare, tornare indietro nel tempo: «La creazione è regressione antropologica dove il conoscere è ricordare il conosciuto lontano»[7]. In questa poetica si collocano le Colle, le Tele acide e, soprattutto, l’esperimento del Museo Attivo dell’Uomo a Monteghirfo, nel quale capovolge il principio duchampiano del ready made e riscopre gli oggetti della cultura contadina dell’entroterra ligure nel loro stesso contesto, lasciandone immutato il significato e il valore. La sua arte diventa così una ricerca antropologica e una scienza alchemica al tempo stesso, nell’intento di cogliere l’essenza ultima dell’uomo e dell’universo, e trova nell’atmosfera dell’ex ospedale psichiatrico un humus favorevole.
Quando Davide Raggio incontra Claudio Costa ha già scelto la via dell’arte per esprimersi e dialogare con il mondo. Ricoverato nell’ospedale psichiatrico in seguito a disturbi psichici legati all’internamento, prima in un campo di prigionia nel 1944 e poi, nel 1950, in un manicomio giudiziario in Argentina, Davide Raggio aveva vissuto i primi anni nell’ospedale in un totale distacco dal mondo circostante. Successivamente ritrova il contatto con la realtà attraverso gli oggetti: inizia a raccogliere pigne, pezzi di legno, radici, conchiglie, e a comporle insieme, assemblandole per dar loro la vita che egli vi scorgeva dentro. Nascono così le Furie, le sculture assemblate con radici e pezzi di legno, forme dal sapore antico e leggiadro al tempo stesso, presenze ad un tempo delicate e travolgenti. Dopo l’incontro con Costa, Raggio sperimenta altri materiali come l’argilla, quella che chiamava “sasso matto”[8], perché pietra friabile che si disfa facilmente, ma anche la cenere, il carbone, tutti elementi, che mescolati con la colla vinilica, diventavano colori grumosi da stendere sopra i cartoni spessi delle scatole da imballaggio. Raggio è, a tutti gli effetti, un artista eclettico, capace di spaziare dalla scultura alla pittura, al disegno.
Nel mare profondo dell’esistenza i cammini dei due artisti si sono incrociati, in un «posto speciale, silenzioso, dove i sassi parlavano e le bacche danzavano»[9], nel luogo dov’era possibile ascoltare il suono interiore di tutte le cose [10] e capire, attraverso l’arte, il proprio essere e l’essenza del mondo. Negli intrecci essenziali del caso, quei due amici, tra le stanze del Museo Attivo, si incontrano ancora, e ci raccontano ancora l’incanto innato dell’universo.
[1] Cfr. G. Mina, Ossessioni, Besa Editrice, Nardò 2009.
[2] Cfr. M. Levo Rosenberg, Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli, ovvero del luogo dove si incontrano coloro che hanno più valore delle cose che fanno, in B. Tosatti (a cura di), Figure dell’anima. Arte irregolare in Europa, Edizioni Mazzotta, Milano, 1997, p. 281.
[3] Ibidem
[4] C. Costa – M- Cristaldi – L. Maccioni – G. Vendemmiati, Il museo attivo delle forme inconsapevoli come presupposto per un cammino di umana conoscenza, in I. M. F. I., Quaderni di ricerca, sperimentazione, documentazione n.9, Museattivo Claudio Costa, Genova 2009, p. 10.
[5] Ivi, p. 14
[6] Cfr. S. Ricaldone, Borderline, un modello tra parentesi. Intervista a Claudio Costa, in I. M. F. I., op. cit., p. 84.
[7]E. Pedrini, Claudio Costa, La ricostruzione dell’umano, in S. Solimano, (a cura di), Claudio Costa, l’ordine rovesciato delle cose, Skira, Milano, 2000, p. 82
[8] D. Menozzi – G. Voltolini, Davide Mansueto Raggio, in B. Tosatti, op. cit., p. 279.
[9] Ibidem
[10] Cfr. V. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, Edizioni SE, Milano 1989, p. 27.
Realizzata con: Hasselblad 500 CM
Pellicola: Kodak T Max 400
Anno: fine anni 80
Luogo: Genova // Ospedale psichiatrico di Quarto
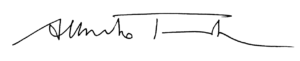
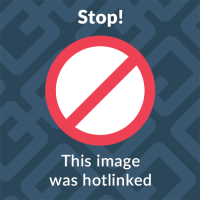









Leave a reply