Varie
Edna O' Brien
In mezzo a tanto vociferare sulla condizione delle donne, chi non la conosce si scopra Edna O’ Brien autrice irlandese classe 1930.
Ragazze di campagna di Edna O’Brien
È l’unico momento in cui sono contenta di essere donna, quell’ora della sera in cui tiro le tende, mi spoglio dei soliti vestiti e mi preparo per uscire. L’eccitazione cresce, minuto per minuto. Mi spazzolo i capelli alla luce della lampada e hanno i colori delle foglie d’autunno sotto il sole. Metto un po’ di ombretto scuro sulle palpebre e mi stupisco dell’aria misteriosa che dona ai miei occhi. Non mi piace essere una donna: vanitosa, frivola, superficiale. Basta dire a una donna che sei innamorato di lei e quella ti chiederà di metterlo nero su bianco, per farlo vedere alle amiche. Ma a quell’ora della sera mi sento sempre felice. Provo tenerezza per il mondo intero.
Edna d’Irlanda. Intervista a Edna O’Brien di Tiziana Lo Porto
C’è una pagina del suo memoir (Country Girl, pubblicato pochi mesi fa in America da Faber and Faber e in uscita a il 27 novembre in Italia per Elliot Edizioni) in cui Edna O’Brien scrive: “Ma ogni libro che sia valido deve essere per certi versi autobiografico, perché non si possono né si devono fabbricare le emozioni”. Autrice amatissima sin dall’uscita nel 1960 del suo primo romanzo, Ragazze di campagna (appena ripubblicato in Italia da Elliot Edizioni), definita da Philip Roth “la più dotata tra le scrittrici contemporanee di lingua inglese”, O’Brien ha raccontato emozioni e cose della vita (spesso della propria, in modo direttamente autobiografico o romanzando, senza mai smettere di restare fedele alla propria e altrui realtà), grandi amori e solitudini, interni piccolo borghesi e paesaggi sconfinati, prevalentemente d’Irlanda.
Nata e cresciuta a Drewsboro, in Irlanda, a ventitré anni sposò lo scrittore Ernest Gébler contro la volontà della propria famiglia. Insieme al marito andò a vivere all’Isola di Man, nel Mar d’Irlanda, ospiti dello scrittore J.P. Donleavys, e poi a Londra, che mai più abbandonò. Diventò madre di due bambini (maschi entrambi), cominciò a scrivere. Quel primo romanzo, rivoluzionario per l’Irlanda puritana del Novecento, fece di lei la scrittrice che è oggi e al tempo stesso segnò la fine del matrimonio con un uomo che proprio non ce la faceva ad accettare l’idea di una moglie che avesse più successo di lui. Come non bastasse, il libro venne odiato dalla madre e bruciato e bandito nella sua amata Irlanda. Un’altra donna al posto di O’Brien si sarebbe arresa per molto meno, lei perseverò. Da allora a ora Edna O’Brien non ha mai smesso di scrivere.
Adesso vive a Londra, ha scritto e pubblicato con successo sedici romanzi, otto raccolte di racconti, poesie, sceneggiature, commedie, biografie (di James Joyce e Lord Byron) e l’ammaliante autobiografico Country Girl, affollato di solitudine e scrittura tanto quanto di party e varie celebrità (Robert Mitchum, RD Laing, Marianne Faithfull, Sean Connery e Jane Fonda tra le sue frequentazioni). Scrive a un certo punto O’Brien: “Non c’era connessione alcuna tra i due mondi, il vertiginoso mondo dei party e lo straziante mondo del lavoro”. E poi, sempre a proposito del costante scollamento tra scrittura e vita, in una delle pagine più illuminanti del memoir: “L’altro giorno ho letto da qualche parte che gli uomini delle caverne non disegnavano quello che vedevano, ma quello che avrebbero voluto vedere”. E poi: “Diciamo che ci sarà sempre letteratura perché l’immaginazione è sconfinata”.
La chiamo al telefono una mattina di luglio, cercando di visualizzarla nella sua Londra che mai più ha lasciato.
Com’è Londra oggi?
Caldissima. Anche troppo calda.
C’è un momento di Country Girl in cui lei scrive: “I luoghi sono il cuore dello scrivere”. Sono davvero così importanti per lei?
Bisogna distinguere i luoghi della mente da quelli reali. L’Irlanda è il posto di cui racconto in quasi tutti i miei libri ma per me è solo un posto della mente. Mentre scrivo sono seduta nel mio appartamento in questa Londra che, tornando alla domanda di prima, oggi è caldissima. Ma con la mente è notte, sono in Irlanda, fa freddo e sono in pericolo.
Country Girl l’ha scritto a Londra?
Quasi tutto. Ma c’ho messo tre anni per finirlo, e nel frattempo mi è capitato di fare dei viaggi. Viaggiando non smetto di scrivere. Poi, per rivivere certe situazioni, sono tornata in Irlanda. Anche se preferisco scrivere a Londra. Mi piace stare qui e vivere la mia vita da eremita. Nelle grandi città hai più privacy. In Irlanda hai sempre gente che ti bussa alla porta o alle finestre per chiederti qualcosa.
Qual è stato il momento più complicato dello scrivere un’autobiografia?
Ripiazzare me stessa, ricollocarmi in certi momenti precisi che sapevo sarebbero stati funzionali alla narrazione. C’è un momento, all’inizio del libro, in cui racconto di essere stata morsa da un cane. Per raccontarlo sono dovuta tornare a quell’età lì, bambina, mentre venivo realmente morsa da quel cane. Ed è così per ogni pezzo del libro, è sempre un ritornare in quel preciso contesto e a quell’età, e da un punto di vista emotivo questa è indubbiamente la parte più complicata. È stato complicato soprattutto quando ho dovuto raccontare il mio matrimonio, la fine del mio matrimonio, la separazione, la battaglia per la custodia dei figli. Mentre ritornavo a quel momento della vita ce l’avevo con me stessa per essere stata, col senno di poi, troppo remissiva. Ma ero in una situazione difficile, e ho fatto del mio meglio per essere coraggiosa.
Alcune delle storie che racconta in Country Girl erano già in Ragazze di campagna. È più facile raccontarsi quando si romanza?
Non credo ci sia una grande differenza. Si tratta sempre e comunque di narrativa, e la scrittura è e dev’essere sempre al centro di tutto. Quando scrivi devi immergerti completamente nel mondo che racconti, indipendentemente dal fatto che lo racconterai in modo veritiero o romanzato. Nel frattempo il mondo interrotto, quello che resta fuori, va tenuto a distanza, e non è facile. Romanzo o autobiografia che sia.
C’è qualcosa della sua vita che ha deciso di non raccontare, di tenere a distanza come il mondo di fuori?
Ci ho messo un sacco di cose in quel libro, in tutto sono centomila caratteri! Ho scritto tutto e a quel tutto ho dato una forma narrativa. Non credo nei memoir che sono liste della spesa di mariti, madri, padri, figli, amanti. La forma, la musica che scegli per raccontare quelle storie lì dev’essere all’altezza delle storie che racconti.
Sapeva già dal suo primo romanzo che sarebbe diventata una scrittrice?
Non voglio sembrare arrogante, ma credo di sì. Volevo esserlo perché sentivo e continuo a sentire che la scrittura è una cosa speciale. È speciale il mio amore per le parole che cerco di trasformare in frasi e per le frasi che cerco di trasformare in romanzi. La scrittura quando è bella è come una sceneggiatura che ha molta più verità della vita. Leggere e scrivere sono i pilastri della mia vita. Sapevo che sarei stata una scrittrice? Non lo so, sapevo che ci avrei provato. E ci sto ancora provando.
In un’intervista dell’84 lei dice: scrivere non è affatto terapeutico.
No, infatti non lo è. Sarebbe facile se lo fosse. Molta gente parla di catarsi, ma non è così. Credo piuttosto che ogni libro porti a un altro più profondo del precedente, e così via, senza sosta, di libro in libro. Scrivere è un viaggio di ricerca, e ogni libro che scrivi ti porta un po’ più in là. Ma questo andare più in là non è mai terapeutico. Uno scrittore serio sa che il tempo e la concentrazione dedicati a ogni libro sono qualcosa di politico, di linguisticamente impegnato, ma non curano solitudine né desolazione. In una delle mie storie c’è una donna che torna nel suo villaggio su un pullman di notte e ricorda momenti della sua vita. E ha bisogno di quella solitudine per ricordare. La scrittura viene da una sorta di solitudine, e non è quel genere di solitudine che viene dagli amori mancati.
E da dove viene?
Dal fatto che la vita non è mai soddisfacente. La letteratura lo è ogni tanto. Così come lo sono la musica o l’arte. Come lo è guardare un quadro di Leonardo Da Vinci o ascoltare della buona musica.
Dal come parla di certi epistolari o memoir di celebri scrittori, sembrerebbe che ama di più le vite vere degli scrittori dei loro romanzi.
No, non faccio che rileggere Shakespeare e Faulkner e Tolstoj ed Emily Dickinson. E poi Proust. E Joyce. La cosa che leggo di più forse è la poesia.
Ne scrive molta di poesia?
Sì, scrivere poesia mi dà il parametro della musica e della precisione. C’è una ricerca dell’esattezza nello scrivere poesia che andrebbe applicato anche alla prosa. Poi chi l’ha detto che la prosa non sia anch’essa poesia? Joyce era un poeta che scriveva in prosa. E come lui molti altri.
Tutti questi scrittori e libri del passato influenzano la sua scrittura più delle persone vere?
No, non puoi scrivere se non frequenti la gente vera. Osservare l’interazione tra le persone è la cosa che ti fa scrivere. Sì, Emily Dickinson c’è riuscita senza frequentare nessuno, ma è stato un caso eccezionale. Direi unico. Noi scrittori dobbiamo mettere un piede nel mondo, osservarlo e trasformarlo in letteratura, prosa o poesia che sia.
Ha anche degli autori o libri preferiti di questo secolo qui?
Ammiro molto W.G. Sebald. Altri non ho molto tempo per leggerli. Ho letto Città aperta del nigeriano Teju Cole, e Yellow Birds di Kevin Powers. Sono entrambi sono libri eccellenti. Ma non mi confino nella scrittura contemporanea. Sì, amo Lydia Davis e Alice Munro. E però torno sempre a Sylvia Plath che come poetessa è stata pari ai greci.
C’è un momento del suo memoir in cui s’interroga sul perché Freud regalò a Virginia Woolf un narciso. L’ha poi scoperto?
Mi piacerebbe, ma no. Mi piacerebbe incontrare Freud o Virginia Woolf e chiederlo direttamente a loro. Perché sì, lo sappiamo che dal narciso derivano tutte le teorie sul narcisismo, ma allo stesso tempo è un fiore bellissimo e Freud potrebbe averlo regalato a Virginia Woolf solo per quello. Non riesco a decidermi su quale delle due sia la risposta, e allora continuo a chiedermelo.
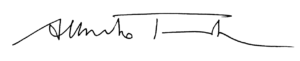
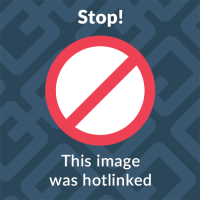








Leave a reply