Varie

L’anarchia di Léo Ferré
L’anarchia è la formulazione politica della disperazione. L’anarchia non è un fatto di solitari: la disperazione neanche. Sono gli altri a informarci sul nostro destino. Sono gli altri a farci, a distruggerci. Con gli altri si è un altro. Allora, distruggendo gli altri, distruggiamo noi stessi. È stato già detto; è importante che sia ripetuto. Il Cristo, il peccato, l’infelicità, il ricco, il povero… viviamo irreggimentati da idee-parola. Niente: siamo dei concettuali, degli astratti.
Una morale dell’anarchia non può concepirsi che nel rifiuto. È rifiutando che si crea. È rifiutando che ci si mette in posizione di attesa, e il tasso di aggressività contenuto nella nostra presa di posizione, nella nostra negatività, è la misura stessa dell’aggressività inversa: tutto è funzione di poli. Siamo dell’elettricità cosciente o che noi crediamo tale, e questo ci deve bastare. I postulati, i teoremi, il quid eterno che è la nostra condizione di homo curiosus, tutto ci porta verso soluzioni di alterità a problemi costruiti da noi. L’enunciato di un problema è sospetto per il fatto stesso di esprimersi in un linguaggio convenzionale. Muller, nel secolo scorso, si preoccupava di sapere perché il passato del verbo to love non è il « passato » che nel suffisso. Loved … e il passato è li, a far mostra di sé, drammatico. Non è niente sentir dire: love; è un presente che ci soddisfa o ci informa, semplicemente. Basta che la desinenza entri in gioco e tutto cambia, oltre lo stesso problema linguistico. Questo d, questo loved suscita immediatamente il rammarico tipico della rivolta civilizzata. Tutto un potenziale di irreversibilità si iscrive in questa lettera che sembra convenzionale e che è solo il risultato di una lunga evoluzione fonetica tendente alla semplicità, alla chiarezza della parola. Una volta sottomessa la grammatica, resta questo strumento, questa parola fattrice di passato, fabbricatrice di coscienza, pensieri, malinconia, storia.
Non abbiamo consapevolezza che le convenzioni – linguistiche, morali, religiose o economiche – ci rinchiudono nel « sociale » come in una tela invisibile che ci consente di fare qualcosa e di pensarla come se, con ogni evidenza, questa cosa fosse una creazione della nostra volontà di fare e pensare, quando invece siamo solo la mosca presa e rimpicciolita da un ragno che osserva senza divorare. L’uomo è mangiato dalla società ma si reinventa in eterno, grazie a una sorta di connivenza incosciente che fa della vittima lo slancio vitale del carnefice. Senza delitto, niente boia, perdiana! Sono i giudici che fanno i delinquenti. Come dice Sartre a proposito del tradimento, la repressione è un delitto avventizio, un crimine di secondo grado che non può mostrare il volto per primo. Per questo le società sono repressive; uccidono su delega, in secondo grado o meglio, di rimbalzo. Uccidono con la Morale, anch’essa tagliente, ma protetta e garantita dalla procedura. La procedura è un modo meccanografico di uccidere il suo prossimo.
La storia dell’Umanità è una statistica della costrizione. Io non credo che nei nostri modo abituali di pensare, ci possa essere una vita possibile senza costrizione. La legge, qualunque sia – foss’ anche la più disinteressata – comprende sempre ciò che sta fuori di essa, il suo contrario, l’anti-legge, ciò che sta dietro la promulgazione. Ci sono nel pensiero del legislatore, angoli bui dove maturano le attività losche necessarie alla giurisprudenza. Una legge contro la tortura non è una legge completa se non prevede la tortura per chi tortura … « Per un occhio, due occhi … per un dente, tutta la faccia » diceva, mi pare, Lenin, con un conturbante senso della metafisica della vendetta e dei suoi interessi composti … Quel che salta agli occhi e alla gola dell’uomo è proprio questa costrizione senza la quale la società non potrebbe sussistere, e si tratta proprio di sussistenza. Questa forza costrittiva, che mi fa vestire al meglio dei canoni della moda contemporanea per non fare ridere quelli che mi guardano, la dice lunga sull’abitudine del cittadino alla regola del questo si fa, questo non si fa. Ciò che mi ossessiona, è la costrizione e perché mai io ci conviva. Mostratemi dunque un uomo in questo universo di matricole ! La distruzione è un ordine inverso. È la negazione del Bene sociale che analizzo nella granata con la miccia accesa. Che cos’è il Bene sociale se non quel che oggi definisco essere il Male, il mio Male, questo Male che mi imbavaglia, che mi sottomette. Scardinata la porta, io rientro nella Città, fiori neri in mano e mi linciano. Entro col mio Bene che diviene il loro supplizio, il loro Male inflitto da me. Sono diventato il diavolo. La costrizione è questo esonero di principio che mi giustifica nella mia prudente obbedienza, vera immagine del civismo.
Obbedisco. Senza un ordine. Obbedisco, perché, membro di questa società, mi ordino di tacere. C’è in ogni domestico una felice disposizione di spirito che lo fa piegare senza che mai gli si rompa la schiena. Le immagine costrittive mi sono proiettate giorno dopo giorno secondo norme acquisite e talmente ramificate in mirabili tecniche che la radio ricevente che mi trasmette le parole d’ordine è regolata – per il suono e per il giusto valore dei punti e delle linee – da me. Ho smesso di pensare tramite me. A casa mia, io penso in particella impersonale: si. L’io è sfigurato da una grammatica nuova che mi disimpara la solitudine e il coraggio. Quel che mi metta a portata di voce della vera vita si è castrato. Ho tagliato la pelle al mio coraggio. Sono ubriaco. In pubblico, se lo tirassi fuori intatto, c’è da scommettere forte che me lo riporterebbero con un catalogo di penalità. Niente diritto privato, niente diritto pubblico; sono parole dottrinali. Non c’è che un diritto: penale. Rien ne va plus nell’obbligazione che mi carico addosso firmando in calce il contratto, senza l’assortimento previsto di costrizioni pecuniarie e se io stesso non mi obbligo. Perché non si assicura la costrizione? Perché la pena non può essere garantita. Essa è assunta da tempo immemorabile. Ne sono io l’artefice. Se la revoco, si rivolta e mi prende a schiaffi. In ginocchio, ritmo la cadenza dei colpi che essa mi porta, sotto l’azione seduttrice, malgrado tutto, della dilazione e della grazia. In questo Bene, in questo Male, mi sento estraneo. Sono uno straniero della Morale. Se il Bene è femmina, il Male lo ara. Un terzo sesso mi interessa di più ed è forse questa l’indifferenza. L’indifferente si è spossessato del suo diritto. Non invoca più niente. Guarda, all’occorrenza, il diritto: segnale d’allarme, via sbarrata, coscienza del fatto sociale. Credo in una relatività giuridica da quando ho colato a picco i postulati che fondano la regola del diritto. Siamo ancora dei romanisti. Il Codice Civile è un trattato pratico di diritto romano rivisto da una sequela rivoluzionaria. Non siamo affatto lontani dal Sacramentum in rem, dall’in jure cessio, e dalle formule dell’antichissimo diritto che sanzionava tale raggiro giuridico. Si è solo proceduto alla «denigrificazione» delle azioni di legge per arrivare a quella operazione ipocrita che salta dall’articolo 1.382 al 1384 e include, se occorre, qualche responsabilità perfino in un’arcata di cemento armato. La responsabilità delle cose ha messo il rischio nel muso del cane. Il padrone morde per procura, è questa la civiltà del diritto: dare un pensiero alla materia inerte, mettere l’uomo al livello della cosa, spersonalizzarlo al punto di trasformare ciò che una morale antica chiamava la colpa in un rischio latente. Il rischio è la colpa predatata.
Da questa macchinazione di cui sono servo, da questa incessante ingerenza delle mie viscere, del mio sangue, dei miei nervi, da questa prigione definitiva in cui sono stato – io, mammifero bipede – mi libero solo con le parole. Il pensiero retto dai miei umori, l’immaginazione che si regola sul già fatto e il già visto mi fanno da inganno supplementare. La mia disperazione è un disperazione chimica. Muoio di morire a ogni istante. Non ho salvezza che nel rifiuto – un inganno di più ma terribilmente sovrattivante. Sono re del mio dolore ed è lui a sottomettermi. In fondo, il dolore sarebbe un piacere, non fosse per il prurito che me lo mette sempre in epigrafe. Sul libro della nostra vita, un parola piena che significa: « Soffri! »
Il cane che urla, un uomo che grida, nulla li differenzia. Mi sento particolarmente « cane » nelle mie ore di isolamento dal mondo. D’altronde, mi prendo le mie facoltà di parola. Non mi parlo mai. Mi canto. Mi matematico. Mi naturo. Parlerò di questa grammatica che ci ha messo la museruola da tanto tempo. Non posso sopportare l’errore di ortografia. La regola, a questo punto ancorata, è al di sopra della regola. È trascesa, direbbe il filosofo… E la regola che si supera diventa « me ». La morale, da qualsiasi parte provenga, è molto vicina a questa autodittatura. Non sono i tiranni a governare. Il mondo è anarchia temperata da regolamenti di solitari e da qualche barema poliziesco.
La proprietà? Bisogna cambiare la parola. Sono proprietario del mio diritto di rivendicare « questa » proprietà, oggetto del mio desiderio e la cui sanzione possessiva è rimessa solo al denaro che mi occorre per diventarne il patrone, a meno che io non mi sia deciso a trasgredire l’ordine stabilito e a impossessarmi di forza o con l’astuzia di un bene che considero, da sempre, dovermi appartenere. E ciò che mi appartiene, posso farlo a pezzi; è questo il diritto di proprietà: il diritto di distruggere… ad libitum ! Il diritto di proprietà sul Van Gogh che ho pagato tre cento milioni, non è quello di metterlo in banca in attesa dei giorni magri, e non è neppure quello di guardarmelo da solo, a casa mia, mugugnando o no sui particolari modi che il pittore aveva di andare al bordello, rasoio in tasca e orecchio in agguato… No, il mio vero diritto di proprietà su quel quadro è di poterlo bruciare, nel mio caminetto, su un rogo di indifferenza, con – nell’occhio e in quella memoria immaginata che non può sbagliare perché tanto le cose vanno sempre nello stesso verso – i critici d’arte dell’epoca che non si sono accorti affatto del genio di Vincent. Quanto a me, io vedo e sono diventato l’unico a « vedere » in questa mia piromania critica!
Non vedo la zuppa del mio cane perché io non mangio « cane ». Non è poi cosi certo come pare, questo fatto. Nel conforto del mio salario, della mia « quindicina », della mia paga, dei mie emolumenti, dei mie onorari (curioso modo di moltiplicare ll lessico della grana …), neppure guardo il cane mangiare. È un mondo che mi è indifferente. Io sono un uomo che mangia e pensa in termini di vitello saltato, caviale fresco o latticini, perché il medico così mi ha raccomandato. Ma questo sistema equilibratore che consisterebbe nel portarmi a livello animale a misurare l’estensione e il territorio della fame, dall’idra fino agli abbonati alla mensa comunitaria, e ad accettare per la mia dispensa delle mosche agghindate sulla tela di ragno mentre mi dico: « Sta bene, io ‘mi ragno’, ne ho ancora per quattro giorni », questo mai. Però… Se muoio di fame, io bruco, sopporto, non penso più al mangiare « cane » o « uomo », ma quel che importa è che io « tenga » perché la società mi ha identificato, mi ha dato un nome, sono figlio di qualcuno. Non è un diritto la filiazione, è uno stato. Un cane che ruba riceve una pedata. Si io rubo un panino, mi mettono dentro. Il mio lavoro mi vale di non essere ai ferri. É meglio piantare chiodi per ore e ore nel planning idiota della merda proletaria che starsene col naso in aria e, a sera, tendere agguati alla « brava » gente e poi andare a fare i conti al commissariato. Il contenzioso correzionale che evito mi rende schiavo di qualcuno e, oggi, di un essere preciso: la società anonima. Alludo con questo, non all’artificio giuridico che mette il Capitale in un’azione quotata in Borsa, ma a quelle facce multiple del marciapiede o della metropolitana, il Popolo, l’humus sul quale spunta ogni quattro o cinque anni quel che si è convenuto chiamare il suffragio universale ! La gente che non vedo non esiste. Se non sono un bandito è perché il Popolo ha votato per far inventare il Procuratore della Repubblica. Il popolo è il foriere della tirannia.
Una psicanalisi della patrimonialità comincerebbe facendo i nomi: il diritto si parla. Il mio patrimonio non potrebbe mai vincere le pretese dello Stato di sottomettermi ai suoi piani di espropriazione, né l’ansia di un vicino che afferma una servitù mezzadrile, se io non produco la prova catastale de il mio « mio ». Che cos’è il « Mio » se non una convenzione comprata ? La mia quercia è mia. La mia quercia è centenaria. Una visione più sana mi dovrebbe dire che è di chi l’ha piantata, della quercia madre della libera natura, del paesaggio di cui essa è un punto mobile nella tempesta o statico nel blu dell’estate. Che è di se stessa, insomma! Il mio rene è mio …
Questa parola che mi incatena al diritto patrimoniale è una parola di circostanza, una parola ammessa, scritta in calce all’atto notarile e trascritta nel registro delle ipoteche, altra certezza di autenticità. La parola è tratta: « autentico ». Mi rimetto alla pergamena, alla scrittura serva di questa parola inventata dal gioco sociale.
Giochiamo a barricarci in parole di possesso: la mia casa, mia moglie, la mia penna, il tuo diritto, il suo cane. Karl Marx non ha sufficientemente meditato sulla coniugazione possessiva – la sola a non temere mai gli errori di ortografia – la coniugazione del mio e del tuo. Tutta l’Economia Politica riposa su un gesto: la mano che dà, la mano che prende. Le teorie sono marginali e non spiegano che una certa psicologia nell’espansione produttiva. Le macrodecisioni hanno dita di acciaio. Il « suo » resta più oggettivo: il suo è una parola di attesa. Il suo è un bene ignorato dal borghese ed è in vetrina per il gangster. Al di fuori delle norme giuridiche – e, singolarmente, delle costrizioni penali – il « suo » perde la sua oggettività: può diventare mio o tuo. In tale prospettiva di linguaggio è bene studiare la psicologia del ladro.
Il ladro, uscito dalla via legale, non prende che un bene vacante, e che è vacante nell’ora della tecnica, nel momento in cui l’armamentario dello scasso è messo in opera, nel momento dell’agguato – che è un lavoro duro e preciso, proprio come quello su un oggetto manifatturato. Il ladro non prende i « suoi » rischi. Assume la sua condizione di ladro: ha contro di sé la legge e a suo favore l’anti-legge, cioè la sua propria legge. È significativo che questa legge detta « della mala », che un romanticismo sommario ha relegato nella mitologia del film poliziesco, sia in realtà una maniera marginale di affermare ugualmente il diritto, o anzi l’anti-diritto. Nel caso della mala, il codice d’onore è un codice del silenzio. Chi parla, chi si accomoda alla mensa dei pentiti è passato al nemico. Il tradimento gli è servito da pedana per il rientro nei ranghi. E i ranghi sono una maniera di attendere la decorazione o il regolamento di conti. In fondo, il tradimento è una morale del benessere sociale, e il borghese tradisce per omissione. Senza situazione giuridica non c’è diritto. Senza la parola che gli dà un nome non c’è albero. Noi facciamo le noste catene: con la regola, con le parole. Per parola intendo -— è ovvio – l’immediato concetto che mi inchioda al discorso interiore. Senza la parola « albero », tutta una fetta della mia conoscenza viene meno: non vedo più foreste, non so più passeggiarci, perdo il fuoco e, perdendo il fuoco, il mio sangue gela, sono perduto per sempre. Sento la disperazione chiamarmi col campanello nella nebbia di questa constatazione. Non parlo più. Non vedo più i nidi, il rinnovo totale ogni volta degli stessi voli, degli stessi gridi, degli stessi canti. Senza alberi dove faranno il nido gli uccelli?
Quando li vedo volare, perché non posso più pensare al movimento delle ali, a quella geometria appresa e che ritrovo nel volo del corvo, quantunque questo, crescendo e gracchiando, turbi i dati magici, anch’essi appresi? Quando vedo un corvo, ritrovo Poe e, con esso, le schede psicanalitiche di Marie Bonaparte, e mi domando chi dei due avrebbe dovuto essere inquisito. Il corvo è diventato, per me, un fatto letterario e io chiamo tutto ciò disperazione. Non so più vedere il corvide. Vedo una forma allusiva del destino e la sua risonanza letteraria o poetica: tre colpi battuti sul vetro.
L’anarchia viene dal didentro. Non c’è un modello di anarchia, né alcuna definizione. Definire, vuol dire confessarsi battuti in partanza. Definire, vuol dire fermare il treno nella notte quando devia sullo scambio. Tanto vale ammettere che si ha fretta di farla finita con la comprensione dell’avvenimento. Proprio per la sua inattitudine di fondo a non sapere definire niente, l’uomo scalpita nelle obiezioni e nella filosofia. Un treno sullo scambio è un lavoro bene fatto, è strada onestamente venduta a me, passeggero, compratore di quella linea notturna che mi conduce a X passando per la deviazione Y, bretella necessaria ma della quale ignoro la ragione deviatoria. Non mi si devia dalla mia strada, me la si rende perfetta e sicura. Quanto a me, io non penso che al rumore infernale e la paura mi pervade. Definisco lo scambio in rapporto al mio problema di solitario che viaggia. Se penso al blocco dispensatore di via libera, ci penso immaginano l’uomo alle manopole e la possibilità di una falsa manovra. Non dò una definizione da ingegnere, non vedo la strada in sezione, nel quale caso rischierei di capire tecnicamente l’incrocio dei binari. Non so che dopo il mio passaggio – ed è proprio questione di MIO e non di un dato oggettivo e cifrato dal traffico – quella valvola si fermerà, delle braccia di ferro si metteranno in guardia per lasciar sfilare verso un punto X il mio simile, quel mio «prossimo» della stazione che ho visto prima lungo il binario, mentre chiamava un facchino e si installava sul treno successivo, a cinque minuti, il treno che mi sta alle costole – e io penso proprio a questo – e che troverà strada libera su quella cifra di ferro torto, oggetto del mio risentimento. Non ci sono solo io nel mondo dei treni. Eppure è proprio ciò a isolarmi completamente dal mondo nel momento preciso in cui — contro ogni evidenza — io mi credo solo, intrappolato in quel veicolo che, al deposito, altro non è che un’astrazione superflua in fuga nella notte. In quella solitudine del muscolo, non mi conosco né mi riconosco alcun padrone, ed ecco che sono costretto a solidarizzare col binario, il binario della mia inquietudine e il binario degli altri, di tutti gli altri. Ho il mezzo di immolarmi a tale paura, e ne ho uno solo, immediato, col quale non oso confrontarmi : il segnale d’allarme, perché al di là di quella maniglia che io credo di sicurezza, c’è un un tariffario di penalità, vero livellamento dell’autonomia, un simplice avviso che mi mette la museruola. Così per l’uomo in società : non osa mai tirare l’allarme, garante di sociabilità.
La parola « solo » è carica di nebbia, è una parola di rifrazione, di luce riflessa, nera, appena sufficiente. È nel « solo » che mi ritrovo ogni sera dopo la pausa dei lavori giornalieri e divertenti. Per strada, il solitario è gradito dall’identico, dal signore che gli cammina davanti e gli riflette quella luce particolare che fa di una schiena comune, curva, la schiena stessa di colui che segue, la chiena dell’attesa. Questa solitudine viscerale è alla portata di tutte le coscienze. Che non ha detto di sentirsi solo in una folla? Luogo comune pietoso che fa di questa folla un crogiuolo di miseria mentale. Appena reclutato, subito imbavagliato, defenestrato, rincantucciato nel luogo comune politico. Ci vogliono luoghi comuni per i tiranni che si puliscono le scarpe nel multiplo della stupidità. I tiranni, oggi, hanno facile gioco. Politicamente, la solitudine è un non senso. Non c’è nemmeno di che fare un solitario nell’arsenale democratico. La cabina elettorale è una piazza pubblica. Questa psicologia del voto segreto è un rigermoglio della confessione. Ci si affida a una scheda per confessarsi. La cabina elettorale, vespasiano senz’acqua, convento del socialismo nell’ora dell’aperitivo… Sbavo di rabbia al pensiero che degli uomini accettino di isolarsi amministrativamente per uno scopo diverso da quello di urinare. La sovranità nazionale perseguita anche in una cabina municipale è qualcosa che mi dà il voltastomaco come una nausea di principio. Le idee che puzzano… non conosco niente di più definitivo nella nostra condizione di Popolo-Sovrano.
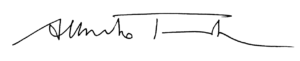
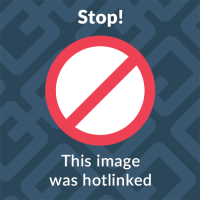





5 Comments
utente anonimo
Alberto: ho facilità a godere dei tuoi scatti, stasera sono priva di strumenti per comprendere il tuo pensiero. Quel che conta per me è l’affetto che ti invio dal gelo dei monti.
albertoterrile
Ho scelto di pubblicare il testo del poeta e chansonnier francese Leo Ferré in cui espone la sua visione del concetto di Anarchia.
Non ho mai amato gli schieramenti, le squadre, sia fossero a destra, al centro, come a sinistra. L’ago della mia bussola in questo senso è fermo.
Ho pubblicato il testo per dare un indicazione….circa la mia direzione…per chi volesse sapere dove e con chi “sto”.
Non ho mai amato la strumentalizzazione della morte che i partiti operano….si scelgono al pari della chiesa dei martiri per portare acqua al loro mulino/pozzo.
Oggi a genova si cavalca la morte del clochard assiderato….anni prima Giuliani…anni prima X….anni prima Y….anni prima…&…..annni prima ¥…
Non vedo dignità per l’essere umano….sebbene abbia sentito dire CHE LA GUERRA HA I SUOI CADUTI….LE LOTTE I LORO MARTIRI….
Il gesto più bello che i COMUNI DELLE GRANDI CITTA DOVREBBERO FARE POLITICAMENTE SOTTO CAPODANNO SAREBBE DIRE:- CON QUESTI SOLDI….I SOLDI CON CUI AVREMMO FATTO IL CAPODANNO IN PIAZZA CHIAMANDO STAR,METTENDO LUCI ….ECCO I SOLDI LI DIVIDEREMO TRA I PRINCIPALI OSPEDALI CITTADINI PER POTENZIARE LE STRUTTURE….SOLDI CHE NON FINISCANO IN TASCHE DI CAMICI….MA REALMENTE ALLE STRUTTURE….
MA…..ogni nostro partito,partitello,partitucolo opera la logica antica del PANEM ET CIRCENSES!!!
Ancora una volta quindi….in alto i calici…mano agli spumanti e Buon Anno….
NB: :
Panem et Circenses
Fu Giovenale a coniare questo sistema, meccanismo di potere influentissimo sulle masse romane. “Panem et Circenses”, letteralmente “pane e giochi” era la formula del benessere popolare e quindi politico: distribuzione di generi alimentari, bagni e terme pubbliche da un lato, gladiatori, belve esotiche, corse coi carri, competizioni sportive e rappresentazioni teatrali dall’altro lato. Un vero strumento in mano agli Imperatori per sedare i malumori popolari, che col tempo ebbero voce proprio in quei luoghi di spettacolo.
albertoterrile
Prendo l’affetto e il gelo dei monti col pensiero.
irazoqui
l’idea di chiedere allo stato di dedicare una piazza a carlo giuliani mi fece venire da vomitare. non si può sputare sul potere e poi chiedergli di commemorarci. sul potere si sputa e basta. lo si manda a fare in culo. e qui si chiude il conto con la sua gelida bestialità.se no si è bambini piccoli bisognosi del padre, altro che uomini in rivolta.
albertoterrile
@ œrazoqui:
Cumm’è la chianta, accussì re ffoglie
(Ogni pianta porta la sua foglia. Tale il padre, tale i figli)
Il Padre si chiama “Potere” e la Madre Democrazia,i loro figli giocano ai giardinetti, rubano le bici agli altri,non dicono mai la verità, si incolpano l’uno l’altro… da una cattiva spina non può mai nascere una buona rosa.